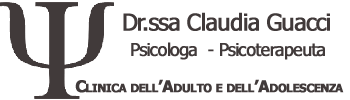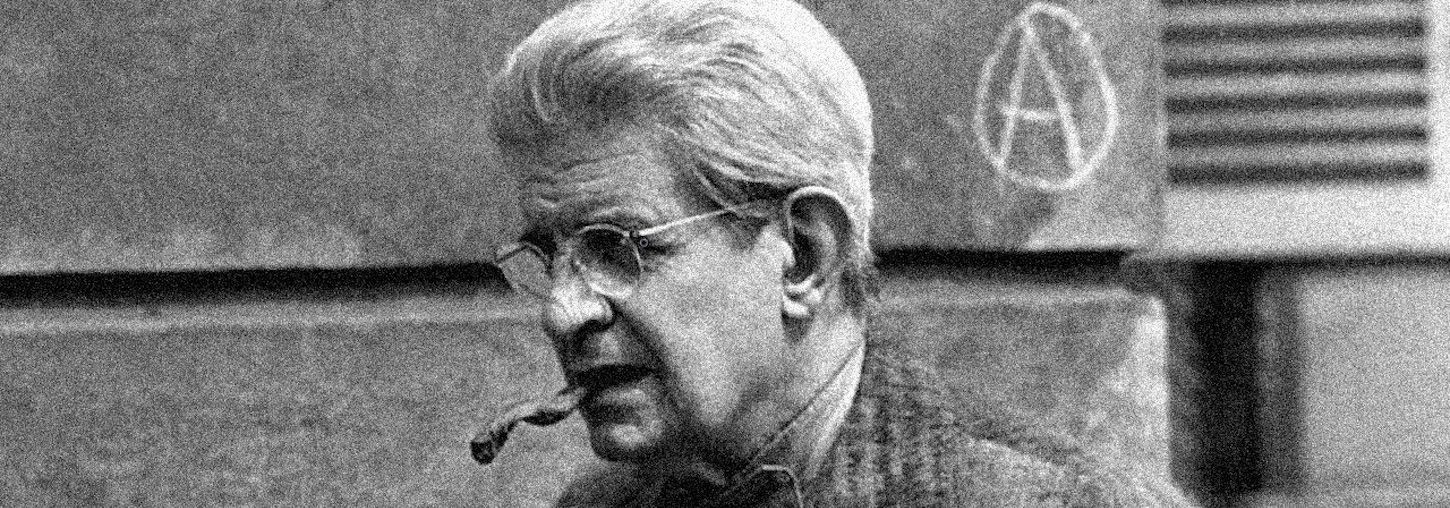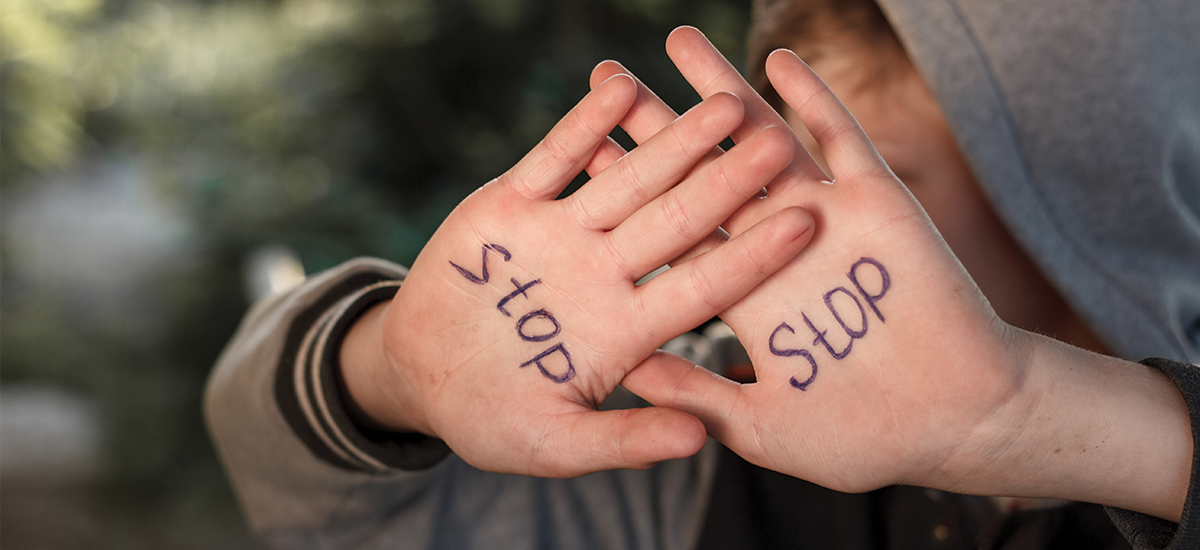Gli Attacchi di Panico
L'angoscia delle mancanze
Nella clinica degli attacchi di panico, rintraccio uno stretto legame tra il panico e l’angoscia. Ritaglierò la questione del panico in rapporto all’angoscia, come modo di trattare l’angoscia, annodata alle conseguenti soluzioni sintomatiche che il fenomeno del panico può offrire al soggetto.
Come si manifesta l’attacco di panico? L’attacco di panico irrompe improvvisamente, oppure accade mentre ci si trova in luoghi affollati, come i centri commerciali, le piazze (agorofobia). Si presenta con palpitazioni o tachicardia, sudorazione, tremori, nausea o dolori addominali, vertigini, paura di morire.
Questo è l’attacco di panico che la diagnosi psichiatrica o di una certa psicologia scientista riduce ad un mero etichettamento diagnostico puntando nella cura ad una normalizzazione del soggetto che pretende di definire in che cosa debba consistere una giusta armonia psicologica uguale per tutti.
La psicoanalisi sceglie un’altra via: per la psicoanalisi il carattere specifico del sintomo non si schiaccia su un disfunzionamento dell’apparato del corpo o del pensiero ma implica, piuttosto, un suo funzionamento paradossale in cui il soggetto dell’inconscio è all’opera e spesso se ne serve per trattare attraverso quel sintomo, l’angoscia.
In questo articolo tratterò la cura del panico nella nevrosi. Cosa va a riparare l’attacco di panico per quanto egodistonico sia? Cosa ci indica del soggetto? Quali congiunture è necessario mettere al lavoro per aprire la possibilità di una esistenza più tollerabile e della vita?
Freud nella sua opera, scritta tra il 1924 e il 1929 dal nome Inibizione sintomo e angoscia, dice che l’angoscia è angoscia di castrazione, angoscia della mancanza; mancanza di cosa? mancanza di un oggetto idealizzato.
Freud fa una distinzione tra angoscia e paura; se la paura ha un oggetto ben definito, paura del buio, paura di guidare la macchina, ecc., l’angoscia è senza oggetto, è indefinita. Alla domanda cosa ti angoscia? ciascuno di noi fa fatica a trovare un nome preciso; di solito l’angoscia è una sensazione diffusa di malessere difficile da circoscrivere in un campo preciso. Freud si occupa molto dell’angoscia ma non altrettanto del panico, piuttosto parlerà di nevrosi d’angoscia.
In Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1924) , Freud indica la Chiesa e l’Esercito come due organizzazioni imperniate sulla logica del padre; il Papa e il comandante rappresentano il padre. Quando in battaglia muore il comandante, cade il capo e l’ideale paterno, i legami libidici si sfaldano, viene meno il legame tra le persone del gruppo e della massa e si scatena il panico. Senza un punto di riferimento verticale, anche i legami orizzontali non tengono: le relazioni tra simili possono funzionare solo se c’è qualcuno che stia a capo. Con la caduta del capo e dei legami si scatena il panico.
Questo è interessante perché spesso il panico accade in contesti, come ad esempio il centro commerciale, affollati ma con un legame libidico piuttosto tenue. Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista milanese riconcettualizza la teoria freudiana della caduta dell’ideale del padre, dell’Ideale dell’Io, con il paradigma dell’ Evaporazione del padre che applica alla clinica contemporanea.
L’evaporazione del padre indica una funzione paterna in declino, dove il padre non occupa più la figura di guida e di testimonianza di un proprio desiderio singolare. La caduta di questo ideale paterno può provocare, a livello individuale, il panico. Lacan usava questa espressione rispetto alle contestazioni giovanili del 68 che avevano demolito l’autorità simbolica del padre nella vita della famiglia.
Nella storia delle persone con attacchi di panico si trova spesso una carenza della funzione paterna, si può dire che sia una «clinica della carenza paterna generalizzata[5]». Il padre reale viene spesso svalorizzato, vengono descritti padri deboli, assenti, padri amati/odiati. Il padre spesso amato nell’infanzia tende poi ad essere vissuto come burbero, come il padre del no.
L’attenuarsi del riferimento al padre fa vacillare molte certezze, relativizza anche gli elementi più solidi e getta talvolta nel panico. Il panico sta ad indicare che il riferimento al padre non riesce più a pacificare il soggetto. In questi termini si coglie l’importanza conferita da chi ha vissuto un attacco di panico all’amore, all’amicizia, a compagni che possano proteggere dallo smarrimento lasciato dalla caduta del padre idealizzato.
Spesso l’individuo che soffre di attacchi di panico si rifugia nell’uso dello psicofarmaco sino a divenirne del tutto dipendente, perché il suo effetto sedativo rassicura, protegge dall’angoscia, ricuce lo strappo della caduta dell’ideale paterno che non garantisce più nulla. Negli attacchi di panico risulta prioritaria la ricerca di un appoggio che spesso si ritrova nel trattamento farmacologico o in un legame simbiotico con la madre.
Nella nevrosi, le paure legate al panico come perdere il controllo, impazzire, morire, possono essere un tentativo di appellarsi ad una funzione paterna, alla funzione del limite, di darsi un limite e questo è interessante se si pensa che quasi sempre ad un attacco di panico segue un’inibizione, della riduzione della vita lavorativa e sociale del soggetto che lo ha vissuto,
In questi casi il trattamento terapeutico mira ad abilitare la dimensione simbolica del padre portando il soggetto a fare i conti con la castrazione del padre e con la sua insufficienza. Per come Lacan dice, non c’è Altro dell’Altro, non c’è un padre che può rispondere al posto del soggetto sulla singolarità delle sue questioni. L’assunzione del proprio desiderio è una responsabilità ineluttabilmente soggettiva, che comporta l’incontro con quello che Jean Paule Sartre definisce l’essere «soli e senza scuse». A partire dalla teoria freudiana dell’angoscia il panico sarebbe il precipitato dell’incontro con la mancanza dell’oggetto idealizzato, dell’incontro con la sfaldatura del legame libidico dell’ideale paterno.
Intreccerò ora la teoria dell’angoscia lacaniana con il panico per offrire un secondo taglio - non per questo in opposizione al primo bensì in tensione tra di loro - attraverso cui leggere clinicamente il fenomeno del panico. Lacan a differenza di Freud dirà che l’angoscia non è senza oggetto. Cosa vuol dire? Per Lacan ciò che angoscia non è la mancanza dell’oggetto, ma la mancanza della sua mancanza. L’angoscia non è più riferita alla perdita d’oggetto ma alla sua presenza, alla sua prossimità eccessiva.
Per Lacan vi è un legame dell’angoscia con il Desiderio della Madre. L’angoscia ha a che fare con l’eccessiva presenza della madre, quando la madre rivolge tutte le sue attenzioni sul bambino, quando il desiderio della madre non si rivolge anche al Padre, come terzo, come funzione del limite tesa a separare la madre dal bambino.
Da questo taglio, il panico sta ad indicare un difetto nel processo di alienazione-separazione, che è quel processo di causazione soggettiva attraverso cui il soggetto si autorizza ad una sua esistenza in rapporto e al contempo separata dal suo Altro genitoriale, ad assumersi un proprio desiderio singolare al di là del desiderio materno. È quel processo che Margaret S. Mahler chiama di individuazione-separazione, il passaggio da uno stato di indifferenziazione con la madre alla realizzazione di un Sè autonomo e separato. Potremmo dire che nel panico il soggetto rimane intrappolato nell’aldiquà del desiderio materno di cui si è fatto ostaggio. In questa direzione il panico può essere una soluzione d’uscita sintomatica da questa presa mortifera.
C’è un troppo, un eccesso pulsionale che il soggetto non riesce a regolare e che attraverso il corpo tenta di espellere. Tendenzialmente nel panico emerge in primo piano il corpo, emerge l’angoscia di non essere più padroni del proprio corpo, che rimanda alla perdita di padronanza corporea nel fare uno con il corpo della madre, alla stato di indifferenziazione tra madre e bambino.
Da qui si comprende come molte persone che soffrono di attacchi di panico portano in seduta un legame simbiotico con la madre da cui fanno molta fatica a separarsi. Un legame che se da un lato viene idealizzato dall’altro toglie il respiro e fa soffocare. I due tagli del panico – panico come caduta dell’ideale paterno e panico come eccessiva prossimità della madre – si intrecciano. Là dove si trova una madre troppo madre, una madre e un figlio in posizione speculare, c’è sempre un difetto della funzione paterna, un padre che non ha funzionato da separatore tra la madre e il bambino, un padre a cui non si è rivolto il desiderio della madre.
Per questo nel trattamento degli attacchi di panico le due questioni – carenza del padre ed eccessiva prossimità della madre - vanno sempre tenute in tensione. La cura allora se da un lato punta a rafforzare la funzione paterna, dall’altro prova ad avviare il processo di alienazione – separazione – puntando a consentire al paziente di accedere ad un proprio desiderio singolare che se pur passando dalle maglie dell’Altro genitoriale non può ridursi a questo.
Bibliografia
S. Freud, Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti(19124-29), in Opere, (vol. 10), tr.it. A.C. C. Musatti , Boringhieri, Torino 2017
S. Freud, L’Io e L’es(1917-23), in Opere, (vol. 9), tr.it. A.C. C. Musatti , Boringhieri, Torino 2017
J. Lacan, Il Seminario, Libro X. L’angoscia (1962-1963). tr.it. A.C. J.A. Miller e A. Di Ciaccia, Einaudi Torino.
J. Lacan (1968), Il mio insegnamento, la sua natura e i suoi fini, , in Id, Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, a cura di A. Di Ciaccia, Astrolabio, 201.
J. Lacan (1968), Il Seminario, Libro XV l’Atto (1967-1968), Traduzione a cura di Sabina Terzani.
M. Recalcati, Elogio dell’inconscio, come fare amicizia con il proprio peggio, Lit Edizioni, 2024, Roma.
M. Recalcati et al, Il soggetto vuoto, clinica psicoanalitica delle nuove forme del sintomo, Erichson Edizioni, 2021, Trento.
M. Recalcati et al, Cosa resta del padre – la paternità nell’epoca ipermoderna, Raffaello Cortina Editori, 2017, Milano
R. Pozzetti, Senza Confini, considerazioni psicoanalitiche sulle crisi di panico, Franco Angeli Editore, 2015, Milano.
J.P. Sartre, L’esistenzialismo è umanismo, Mursia Editore, Milano, 2016